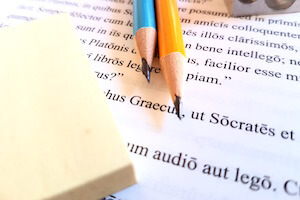
Liceo classico e liceo scientifico, in particolar modo, rimangono percorsi quasi invariati da generazioni: sono saldamente ancorati alla pedagogia tradizionale, fatta esclusivamente di lezioni frontali, con programmi in cui prevale la teoria sull’applicazione (per le scienze), la storia del pensiero sullo studio del pensiero (per la filosofia), la grammatica e la traduzione sulla capacità di parlare e di comprendere (per le lingue – vive o morte che siano).
Ecco, le lingue “morte”. Parliamo delle lingue cosiddette morte.
Il latino é una materia obbligatoria in molti licei. Sempre più persone sono perplesse sullo studio del latino perché affermano che non é “utile”.
Trovo l’argomento dell’utilità del tutto fallace. Mi spiego: molte cose che si studiano non sono immediatamente utili e rientrano tutte nel campo di ciò che chiamiamo “cultura”. E poi avere una cultura é utile per comprendere il mondo.
Ora, il latino é cultura, la cultura da cui proveniamo. Su questo penso siano tutti d’accordo. Ma quanti altri saperi lo sono? Sono “cultura” anche la linguistica e la statistica, l’economia e la psicologia, così come tante altre discipline che ci aiutano a capire il mondo. Allora perché il latino si e la teoria musicale o la pratica di uno strumento musicale no?
Mi si dirà che il ventaglio delle materie studiabili a scuola non é infinito: é ovvio che bisogna fare delle scelte, ma ha senso perpetuare le scelte del passato senza metterle in discussione? E’ qui il punto.
Nel tentativo di risolvere la questione del come mai si dia ancora tanta importanza al latino, sono andata a leggere uno studio che consiglio a chiunque sia interessato al tema.
E’ della Associazione TreeLLLe e si chiama “Latino perché? Latino per chi?” (2008). Si trova facilmente sul web (sul sito www.treellle.org, in particolare cliccando qui) e si può scaricare gratuitamente. E’ una lettura veramente istruttiva. Contiene diversi saggi; due sono degli ex Ministri della Pubblica Istruzione Tullio De Mauro e Luigi Berlinguer, gli altri di Françoise Waquet, Carlo Bernardini, Maurizio Bettini, Rosario Drago e Leopoldo Gamberale.
La ricerca di TreeLLLE muove dalla domanda se il latino debba essere mantenuto come percorso obbligatorio (ed eventualmente, se mantenuto, per quali indirizzi scolastici) ovvero sia da rendere opzionale o da abolire.
I vari studiosi, nei loro contributi, danno soluzioni diverse alla questione, ma più delle soluzioni, sono interessanti i ragionamenti che vi vengono svolti.
Le considerazioni che seguono sono in gran parte riprese da questo studio. Per semplificare questo ‘post’ ho volutamente ignorato le regole canoniche della citazione scientifica, per cui non ho virgolettato né attribuito le affermazioni che seguono ai vari autori. Di ciò mi scuso, ma è per rendere il tutto più scorrevole. Insomma: riassumo alcuni degli argomenti dello studio citato con l’avvertenza che, se le conclusioni sono mie, tuttavia qua e là ho preso di sana pianta intere frasi.
Perché il latino? L’eccezionalità del caso italiano risiede dal permanere della obbligatorietà dello studio del latino, contro l’opzionalità scelta da altri paesi. Da ciò deriva che, ad esempio, nel 2005, gli studenti impegnati nell’apprendimento del latino erano in Italia ben il 41% dell’intera popolazione studentesca della scuola secondaria, contro il 2% della Gran Bretagna o il 5-8 % della Germania. L’alta percentuale italiana si spiega perché, come tutti sappiamo bene, il latino è previsto nel curricolo di molti licei e non solo al classico.
Ma come mai lo studio nel latino nei secoli è rimasto tanto importante? E’ il saggio di Françoise Waquet a spiegarlo. Ho stentato anche io a credervi all’inizio ma la verità è che quando il latino non è stato considerato più fondamentale alla vita civile, i suoi difensori si sono inventati dei motivi “intellettuali” per la sua conservazione nell’educazione scolastica.
Si tratta di argomentazioni enunciate prima della fine del XVIII secolo e spesso giunte intatte sino a noi. Chiamiamo queste argomentazioni “i pregiudizi sul latino”:
Eccoli:
- che lo studio del latino sia benefico per le facoltà intellettuali dei giovani, ossia che sviluppando logica e memoria abitui al ragionamento. Il latino è dunque visto come una “ginnastica mentale”, da cui l’ossessione per un approccio di tipo “grammaticale” alla lingua e la famosa frase udita da generazioni di studenti secondo la quale il latino – più di qualsiasi altre discplina – “forma la mente”;
- che il latino, sviluppando le facoltà intellettuali dei giovani, favorisca lo studio di altre materie astratte, come le scienze matematiche;
- che il latino educhi al bello e al bene: insomma che sia materia portatrice di sensibilità estetica e morale. Che serva, quindi, alla formazione completa dell’uomo, serva a fortificare il carattere, che rappresenti addirittura i valori fondamentali dell’umanità.
Se lo studio del latino è una ‘ginnastica mentale’, si tratta di una “ginnastica” nè migliore nè peggiore di altre. E’ vero che, essendo il latino una lingua flessiva, la traduzione richiede uno sforzo di tipo logico. Ma questo riguarda la traduzione dall’italiano al latino e non viceversa. Nella traduzione dal latino all’italiano è ben noto che in alcuni casi si va ad intuito, per via della vicinanza tra le lingue. Così facendo, spesso ci si prende, ma altre volte si prendono cantonate. E a ragionare non si impara mai.
Inoltre, non necessariamente la capacità di ragionare sulla frase latina per capirne il significato e tradurlo in un’altra lingua, “forma la mente” nel senso di rendere l’individuo latinista più abile ad applicare il ragionamento ad altre materie o alle situazioni della vita. Insomma: saper tradurre il latino non fa diventare la persona un problem solver.
Che il latino – esso solo – educhi al bello e al bene…certamente, ma forse non è necessario conoscere il latino per assaporare il bello e il bene. Chi legge Seneca o Platone in traduzione è figlio di un dio minore? E la storia dell’arte non potrebbe anch’essa educare al bello, così come l’ascolto di Bach o del Concerto di Colonia di Keith Jarrett?
La ripetizione secolare degli stessi argomenti, di questi “pregiudizi sul latino”, ha trasformato tali argomenti in verità di fatto, poco importa che siano indimostrabili. L’unico pregiudizio sul latino che ha fondamento è, forse, che sia utile (ma non necessario) a conoscere meglio altre lingue vive, ad esempio il tedesco (in quanto lingua flessiva), ovviamente le lingue neolatine (perchè da questo derivate) ma anche l’inglese (infatti – sorprenderà – ma solo il 10% del vocabolario inglese è di matrice germanica!).
Tuttavia questo “essere utile” può essere detto di qualsiasi lingua: come sanno bene i poliglotti, lo studio di una nuova lingua aiuta la comprensione delle altre lingue, specie se dello stesso ceppo.
La questione rimane aperta.
Ti potrebbero anche interessare: